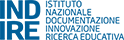La risorsa prende in esame origine, dinamica ed effetti dei sismi. Spazi significativi sono dedicati sia all’esperienza pratica (con utilizzo di materiali poveri e con riferimenti a situazioni reali) da costruire assieme agli alunni, sia alle attività di ricerca dati, simulazioni, video, foto, ecc., attraverso siti Internet, con la finalità di far acquisire loro la consapevolezza delle relazioni che intercorrono fra dinamica delle placche – fenomeni sismici – attività vulcanica. Infine si propone una trattazione delle tematiche rivolte alla prevenzione e riduzione del rischio sismico con l’obiettivo sia di sviluppare atteggiamenti corretti in caso di evento tellurico, sia di costruire una cultura basata sullo sviluppo sostenibile attraverso una corretta pianificazione territoriale.
Grado scolastico: Secondaria di I grado – III anno
Obiettivi:
• Contribuire a costruire un concetto di fenomeno sismico come risposta (effetto) alla dinamica endogena della Terra (causa).
• Modellizzare strutture e fenomeni naturali difficilmente osservabili nel loro complesso operando le adeguate riduzioni di scala, tenendo presente la qualità del dato ottenuto e la sua attendibilità/estendibilità alla realtà.
• Fornire agli studenti strumenti di lettura analitica e critica della complessità del mondo naturale, stimolando l’applicazione delle fasi del metodo scientifico in contesti reali.
Competenze:
• Partendo dal bagaglio di conoscenze degli studenti, saper organizzare, animare e facilitare situazioni di apprendimento significativo di conoscenze, abilità e competenze, mediante la realizzazione, il più possibile condivisa, di percorsi laboratoriali di ricerca-azione.
• Stimolare l’operatività e l’interazione diretta degli alunni con gli oggetti e le idee coinvolti nell’osservazione, nelle sperimentazione e nello studio, dedicando ampi spazi alla discussione, al dialogo, al confronto (cooperative learning), alla riflessione su quello che si fa, al problem setting/solving, al fine di costruire “strutture logiche di pensiero”.
• Favorire l’autonomia operativa degli allievi, contemplando la possibilità dell’errore al fine di far loro riflettere sull’operato e ricercare strategie correttive.
• Essere disponibili ad apprendere l’uso di nuove strumentazioni o di nuovi programmi informatici.
Tempo medio per svolgere il percorso in classe: 22 ore
Prova di valutazione correlata:
Il mondo trema (di M. Onida)