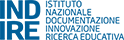L’acqua è una risorsa fondamentale per il nostro pianeta in quanto è indispensabile per l’esistenza della vita in generale, oltre che per soddisfare le esigenze primarie dell’uomo.
Questo percorso didattico intende guidare gli alunni, partendo da uno o più problemi reali (ad es. carenza della risorsa idrica, necessità di tutelare le falde acquifere, inquinamento del mare da sversamento di idrocarburi, ecc.), alla scoperta dell’importanza dell’acqua per la vita dell’uomo e degli ecosistemi (legata alle proprietà chimico-fisiche della sua molecola) e quindi a una riflessione sui comportamenti da assumere per la sua tutela.
Grado scolastico: Secondaria di I grado – classe I, II, III
Obiettivi:
• Imparare ad annotare sistematicamente le osservazioni compiute (anche attraverso l’esecuzione di misure dirette e indirette, utilizzando le unità di misura del Sistema Internazionale adeguate al problema) al fine di poterle analizzare proficuamente in tempi successivi.
• Descrivere correttamente i dispositivi usati, le osservazioni o le misure effettuate, i risultati ottenuti.
• Riconoscere nelle situazioni esemplari affrontate i collegamenti con altre situazioni incontrate in contesto quotidiano.
• Analizzare le problematiche relative alla risorsa idrica (sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo), in particolare affrontando lo studio di alcuni tipi di inquinamento idrico, le loro cause e le conseguenze.
Competenze:
• Riconoscere cause ed effetti nei fenomeni considerati.
• Individuare domande chiave (problem posing) sia a partire dai dati raccolti sia a partire dall’esperienza quotidiana.
• Fare predizioni appropriate e giustificarle.
• Organizzare correttamente le osservazioni e pianificare semplici attività di investigazione.
• Ricostruire e comunicare il senso logico delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi proposti.
• Valutare argomentazioni e prove scientifiche riportate da diversi “media”(giornali, internet, riviste specializzate, ecc.).
Tempo medio per svolgere il percorso in classe: 40 ore
Prova di valutazione correlate:
Non tutte le acque sono uguali (di M. V. Massida)