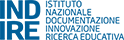Tra gli obiettivi che questo percorso didattico si pone vi sono quelli di potenziare la capacità di analisi delle caratteristiche formali e semantiche del lessico, introdurre i concetti di base relativi alla memorizzazione e sensibilizzare i docenti sulla differenza tra pratiche esercitative per la percezione e per la produzione del lessico (input, storage e retrieval).
Il percorso si rivolge a docenti di italiano L1 ed L2 e docenti di italiano in classi plurilingue.