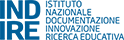Le modalità di misurazione delle competenze acquisite in lingua straniera e i criteri di valutazione di cui tenere conto sono particolarmente legati alla competenza d’uso della lingua in contesti comunicativi e si collocano coerentemente all’interno dell’approccio metodologico più diffuso, il cosiddetto “approccio comunicativo”. Il testing e la valutazione in lingua straniera hanno seguito l’evolversi progressivo della didattica delle lingue conformandosi, sia nei contenuti sia negli approcci, ai mutamenti che l’hanno contrassegnata.
In questo percorso si propone un’analisi delle forme di valutazione adottabili per le singole attività comunicative: comprensione orale, comprensione scritta, produzione e interazione orale, produzione e interazione scritta.