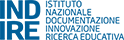Questa risorsa si basa sull’importanza del possesso di una competenza comunicativa consapevole e funzionale ai vari contesti d’azione, nel mondo attuale così come nell’antichità, importanza sottolineata attraverso una comparazione fra il bilinguismo antico e il bilinguismo odierno.
La proposta, finalizzata sia a recuperare e potenziare l’uso della lingua italiana sia ad acquisire progressivamente la consapevolezza del suo funzionamento, con la focalizzazione delle sue origini, attiva nel discente la coscienza linguistica.