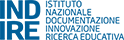Il primo giorno di scuola è come la pagina bianca di uno scrittore quando decide di iniziare un romanzo, di un giornalista che debba scrivere un articolo, di uno scienziato che voglia divulgare in un saggio la sua ricerca.
L’inizio è sempre un momento di “crisi”, nel suo senso etimologico di “scelta”, dal greco krísis. Orazio, che di pagine bianche ne ha avute davanti molte nella sua esemplare avventura poetica, dice: dimidium facti, qui coepit, habet (Epistole 1, 2, 40), che noi traduciamo liberamente: “chi ben comincia è già a metà dell’opera”.
Questo percorso suggerisce qualche soluzione per la krísis dei primi giorni di scuola, offrendo percorsi di scoperta e di studio su brevi testi latini, facilmente comprensibili anche per chi non sa ancora il latino. Può valere sia nei quattro indirizzi liceali dove la disciplina è prevista nel curriculum: classico, scientifico, scienze umane e linguistico, sia negli altri indirizzi, dove il latino non è previsto come disciplina specifica.
Da una parte, quindi, l’analisi di un corpus pur limitato di parole (150) è l’occasione per l’apprendimento e la memorizzazione del lessico latino e del lessico italiano derivato, di alcune strutture grammaticali latine e delle corrispondenti strutture grammaticali italiane (individuazione delle parti del discorso, categorie grammaticali del nome e del verbo); dall’altra lo studio di elementi della cultura e della civiltà latina, è l’occasione per riscontri interdisciplinari con altre materie: l’italiano per la parte linguistica, la storia per la parte documentaria, la matematica e le scienze per la parte scientifica che riguarda la misurazione del tempo, i movimenti della terra e del sole, la terminologia relativa alle meridiane.