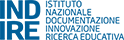Questo percorso didattico è un percorso di lavoro ideato e strutturato in un’ottica di continuità e trasversalità con l’esperienza astronomica descritta nel percorso “Tra Cielo e Terra”. In questo percorso la protagonista è l’ombra. Vengono proposti alcuni giochi all’aperto con la propria ombra non solo per stimolare i ragazzi a ricordare esperienze passate, ma soprattutto per realizzare con il proprio corpo modelli utili per interpretare i fatti e i fenomeni astronomici (angoli del Sole, eclissi, ecc.). In particolare si cerca di ricreare la naturale interdisciplinarietà con la geometria euclidea concretizzando concetti astratti: parallelismo dei raggi solari, propagazione rettilinea della luce, similitudine tra triangoli rettangoli, spazi d’ombra, lunghezze delle ombre e ampiezze di angoli.
Grado scolastico: Secondaria di I grado – classe II e III
Obiettivi:
• Saper individuare cambiamenti nel tempo dell’ombra di un bastone rispetto a parametri lineari e angolari.
• Mettere in relazione l’ombra di un bastone con l’altezza del Sole sull’orizzonte.
• Saper applicare metodi geometrici (cerchi Indu) per individuare il meridiano locale NORD-SUD e di conseguenza la linea EST-OVEST.
• Sapersi orientare utilizzando i punti cardinali.
• Individuare nei triangoli rettangoli verticali l’angolo che indica l’altezza del Sole sull’orizzonte.
• Distinguere tra spazio d’ombra e figura d’ombra.
• Riconoscere nelle penombre spazi parzialmente illuminati.
• Riconoscere dal contorno della figura d’ombra quando una sorgente luminosa può essere considerata puntiforme.
• Comprendere che per poter vedere servono: le sorgenti che emettono luce (sorgenti primarie), oggetti che rimandano luce (sorgenti secondarie) – gli occhi che ricevono luce e mandano segnali al cervello.
• Distinguere i corpi in base al diverso comportamento della luce.
• Mettere in relazione il grado di trasparenza/opacità con l’assorbimento selettivo o non selettivo.
• Saper documentare il lavoro con: relazioni, disegni, foto, prodotti multimediali.
• Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico.
Competenze:
• Ricordare e applicare alla situazione problematica la conoscenza scientifica necessaria.
• Confrontare e correlare oggetti e fenomeni della realtà circostante, individuando somiglianze e differenze e operando seriazioni e classificazioni.
• Formulare domande (problem posing), sia a partire dai dati raccolti sia a partire dall’esperienza quotidiana.
• Raccogliere dati in contesti diversi, sia in situazioni controllate (laboratorio) sia sul campo, utilizzando diversi tipi di strumenti.
• Analizzare ed interpretare i dati raccolti per trarne conclusioni appropriate.
Tempo medio per svolgere il percorso didattico: 25 ore nel corso dell’anno
Prova di valutazione correlata:
Un’estate al mare (rielaborazione a cura di M. Onida)