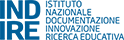La risorsa presenta alcune domande-guida per condurre una riflessione iniziale sul rapporto tra la progettazione didattica nel biennio della scuola superiore e le sue concrete modalità di attuazione e alcuni dei criteri fondamentali della indagine PISA sulle competenze di lettura.
L’approccio proposto è empirico e parziale, solamente propedeutico ad un’impegnativa riflessione che rimetta in discussione gli obiettivi di apprendimento legati alla definizione delle competenze di lettura degli studenti tra i 14 e i 16 anni, impegnati in un segmento scolastico che continua a rivelare forti incertezze e criticità. Non si tratta certo soltanto di definire tipologie testuali e modalità di formulazione delle relative domande, ma soprattutto di chiedersi cosa intendiamo facendo riferimento ad abilità di comprensione, interpretazione, valutazione e riflessione inerenti al processo di lettura. Si tratta inoltre di confrontare ciò che facciamo a scuola con i criteri e i risultati dell’indagine OCSE-PISA, di rinvenire limiti e suggerimenti presenti nelle due esperienze. E magari trovare risposte e proposte provvisorie, ma esperibili e utili.
Homepage
[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]
Ultime guide pubblicate
Dalla comprensione al commento
Indagine OCSE-PISA: inquadramento metodologico e livelli di competenza verificati
Questo percorso si pone varie finalità: innanzitutto intende fornire informazioni relative alle indagini OCSE-PISA e consentire l’accesso alla relativa documentazione, invitando poi a osservare, analizzare e discutere i criteri adottati nelle indagini in riferimento alla lettura e comprensione dei testi. L’attività stimola poi, sempre sulla base degli stimoli offerti dall’indagine, la formulazione e la discussione di ipotesi di progettazione educativa e di verifica delle modalità pratiche in relazione ad alcune componenti della comprensione del testo che possono essere verificate e valutate con una prova strutturata.
Una finalità in parte implicita, ma essenziale, è quella di far riflettere e dibattere sui rischi di retroattività che ogni forma di valutazione comporta, e in particolare sul rischio di adattare la progettazione e l’attività didattica non a finalità e progetti condivisi, ma alle pratiche di valutazione, siano esse individuali, di classe, di scuola, di sistema o internazionali.
La didattica della lettura, comprensione e riscrittura dei testi
Il Materiale di studio “La didattica della lettura, comprensione e riscrittura dei testi” è strutturato in questa scheda introduttiva e in quattro percorsi operativi.
La scheda (che può essere consultata a video sotto forma di semplice ipertesto, ma è anche fornita in versione pdf da stampare e leggere su supporto cartaceo) ha queste finalità:
– esporre in modo estremamente sintetico alcune questioni di carattere teorico e metodologico sulla lettura e la comprensione, maturate nell’ultimo quarto del secolo scorso, selezionate e filtrate unicamente in base alla significatività e funzionalità in prospettiva pedagogica e didattica (ovvero chiedendosi che cosa serve al docente);
– fornire materiali allegati per l’approfondimento di alcune tematiche e una serie di spunti e di indicazioni bibliografiche per ulteriori ricerche;
– fornire indirettamente una metodologia e alcuni esempi che chi legge la scheda potrà variamente utilizzare nella progettazione di unità formative introduttive sulla didattica della lettura; vanno in questa direzione sia gli esempi forniti che gli inviti alla discussione;
– familiarizzare operativamente il fruitore con le caratteristiche e le differenze della lettura a video o su supporto cartaceo, invitandolo a riflettere criticamente sulla specificità delle due procedure, nella consapevolezza che il corso di formazione che gestirà sia, forse, le attività didattiche che proverà a promuovere faranno uso di entrambi i supporti; certamente in entrambi vivranno immersi gli allievi cui guardano, alla fine, queste pagine.
La scheda è corredata da alcuni allegati, da una bibliografia (che comprende anche i riferimenti relativi ai percorsi operativi) e da rimandi al glossario consultabili online attraverso link e “parole calde”, ma disponibili anche su supporto cartaceo.
Rispetto ai percorsi, la scheda ha solo in parte una strutturazione più espositiva e introduce alcune componenti metodologiche e operative che saranno poi dominanti nei quattro percorsi:
Percorso 1. Indagine OCSE-PISA: inquadramento metodolgico e livelli di competenza verificati (M. Ambel);
Percorso 2. Gli ambienti digitali di riscrittura e scrittura di testi (M. Ambel e M. Guastavigna);
Percorso 3. Dall’analisi al commento: la lettura e la riscrittura sui testi letterari (M. Ambel e M. Serra);
Percorso 4. Leggere in/le lingue altre rispetto a quella/e dell’apprendimento nell’infanzia (C. Dell’Ascenza e A. M. Curci);
Percorso 5. Analisi e interpretazione (A. Colombo).
I percorsi hanno finalità e impianto metodologico differenti rispetto a questa scheda:
– su ogni argomento affrontato forniscono una traccia di lavoro, spunti problematici e materiali per la progettazione e la messa in atto di unità formative per docenti di scuola superiore;
– esemplificano alcune procedure didattiche da svolgere in classe nella prospettiva di un loro uso anche come modelli per ulteriori elaborazioni da parte del gruppo di docenti in formazione;
– sollecitano la discussione e il confronto cooperativo fra i docenti per favorire lo scambio di ipotesi e la costruzione condivisa di possibili soluzioni.
Tutti i percorsi sono rivolti alla didattica del biennio della scuola superiore, nella prospettiva curricolare di forti componenti “di cittadinanza” unitarie e trasversali a tutti i tipi di scuola e di componenti più propriamente di indirizzo e legate alla specificità di ogni singolo contesto.
La frase semplice secondo il modello valenziale: italiano e latino per la scuola secondaria di secondo grado
Il percorso qui proposto si inserisce nel quadro generale di un possibile progetto curricolare relativo alla trattazione della frase semplice nei diversi ordini di scuola (secondaria di primo e di secondo grado). Costruire un curricolo “realistico” e applicabile concretamente non è cosa semplice, soprattutto se consideriamo che allo stato attuale è difficile raccordare le azioni persino in un ambiente come quello degli istituti comprensivi (primo ciclo scolastico) creato proprio per favorire la continuità.
Il percorso affronta la tematica dell’analisi della frase nucleare secondo il modello della grammatica valenziale in un’ottica plurilinguistica e l’obiettivo che esso si pone è quello di elaborare un percorso che sviluppi gli elementi fondamentali per una grammatica della dipendenza di base.
Alla scoperta dei determinanti. Una riflessione contrastiva fra italiano e inglese – Due percorsi per due livelli scolastici
Il lavoro che qui presentiamo è una proposta didattica che vuole rendere operative alcune recenti riflessioni teoriche di Colombo, di Marina e di Bondi Paganelli sui nodi fondamentali della categoria grammaticale dei determinanti in una prospettiva plurilinguistica.
Alla base della nostra riflessione stanno una serie di presupposti:
– gli studenti di qualunque ordine di scuola faticano – quando non falliscono del tutto – a mettere a confronto i due o tre sistemi linguistici di cui studiano le regole e i segni, cioè la grammatica, vivendoli come “materie” diverse;
– lo studio dell’italiano (come L1) è una riflessione “a posteriori”, visto che si è appresa tale lingua da piccoli, per imitazione, non certo a partire da un sistema di regole. È proprio su tale studio che si può costruire una “grammatica generale” di riferimento anche per lo studio delle lingue straniere e delle lingue classiche;
– diverso il caso degli stranieri che giungono in Italia in età scolare e per i quali l’apprendimento dell’italiano (L2) è “supportato” dalla riflessione sulla lingua. Inoltre questi studenti, che sognano e formulano pensieri nella loro lingua madre, si comportano nei confronti dell’italiano come i nostri studenti nei confronti di una lingua straniera: utilizzano maggiormente le strutture della lingua madre quando devono esprimere opinioni e idee più complesse. Importante è quindi l’osservazione delle interferenze linguistiche che dovrebbe fornirci preziose indicazioni sulla “lingua da insegnare” e sulle priorità;
– lo studio della grammatica, in genere, è vissuto passivamente dai ragazzi, come pura “materia” scolastica avulsa dal loro vissuto. Quello che si definisce “apprendimento”, invece di essere una trasformazione delle proprie conoscenze sulla base dell’esperienza, diventa un’acquisizione o un trasferimento di significati stabiliti a priori. Proprio per questo, spesso non vi è nei ragazzi la consapevolezza delle molteplici funzioni di tale studio.
La frase semplice secondo il modello valenziale: italiano per la scuola secondaria di primo grado
La risorsa si inserisce nel quadro generale di un possibile progetto curricolare relativo alla trattazione della frase semplice nei diversi ordini di scuola (secondaria di primo e di secondo grado).
Costruire un curricolo “realistico” e applicabile concretamente non è cosa semplice, soprattutto se consideriamo che allo stato attuale è difficile raccordare le azioni persino in un ambiente, come quello degli istituti comprensivi, creato proprio per favorire proprio la continuità.
Le difficoltà di realizzazione e applicazione di un curricolo simile sono diverse. Fra queste:
– condividere un modello di analisi;
– condividere la terminologia;
– realizzare ad ogni livello scolastico l’analisi degli elementi per il grado di approfondimento ad esso adeguato;
– avere possibilità di momenti di incontro, dialogo e discussione, confronto fra insegnanti di livelli scolastici diversi e indirizzi diversi.
La risorsa non può ovviamente sviluppare tutti i contenuti previsti, ma tratta quelli che, in un ordine cronologico, possono venire prima.
The English simple sentence through the valency approach: activity pack for lower secondary learners
This mini-syllabus is part of a broader framework of a wishful syllabus focusing on the simple sentence in lower and upper secondary Italian state school context. This mini-syllabus was designed for lower secondary learning context, focusing on English as a foreign language.
Descrivere le lingue: quale metalinguaggio per un’educazione linguistica efficace?
“Metalinguaggio” è l’insieme di termini, nozioni e discorsi che si fanno sul linguaggio. Appartengono al metalinguaggio parole d’uso comune come “parola”, “frase”, “discorso”, “discussione”, “domanda” o espressioni più tecniche come “aggettivo”, “verbo”, “coniugazione”, “periodo”, “testo”, “subordinata causale”, “complemento predicativo del soggetto”.
Il metalinguaggio però non consiste solo di termini, ma anche di frasi e discorsi. Affermazioni come “Questa parola è più ricercata di quest’altra”, “Questa frase è molto lunga”, “In questo periodo si trovano due subordinate”, “Il tedesco è una lingua con una morfologia molto ricca”, “Il plurale dei nomi in inglese si forma aggiungendo una -s” hanno tutte un carattere metalinguistico. Come si vede, i discorsi metalinguistici si trovano nella conversazione quotidiana, nella prassi scolastica e nella ricerca in linguistica: essi hanno dunque un ruolo importante nella nostra vita e risultano centrali in qualunque pratica di educazione linguistica.
La grammatica della dipendenza: un approccio integrato italiano-lingue classiche
Il fine primario dell’insegnamento delle lingue classiche nel biennio nella scuola superiore è quello di dotare gli alunni, entro un breve arco di tempo, degli strumenti indispensabili per pervenire alla comprensione dei testi d’autore. L’obiettivo della comprensione, che è altro dalla traduzione e tuttavia predispone alla consapevole ricodificazione del testo in altra lingua, deve essere raggiunto oggi in tempi più brevi di quanto non consenta l’approccio analitico tradizionale.
Da qui la necessità di attivare, fin dal primo anno di studio, strategie alternative che permettano di:
– accelerare il possesso delle tecniche di scomposizione del testo;
– focalizzare come irrinunciabile il riconoscimento delle strutture sintattiche della frase e del periodo e il riconoscimento delle loro funzioni in rapporto al significato complessivo del testo;
– scomporre il processo con cui avviene la comprensione, per meglio individuare le cause d’errore.
La grammatica della dipendenza offre al docente un modello pratico, perché necessita di pochi prerequisiti nell’allievo; economico, perché consente apprendimenti trasversali (alla lingua madre, alle lingue classiche e a buona parte delle lingue moderne comunitarie), prestandosi così ad una programmazione linguistica integrata; rigoroso, perché si fonda su un metodo e offre strumenti (cioè concetti fondamentali di linguistica generale) che facilitano la comprensione dei testi scritti. È infine un modello capace di dialogare con il metodo analitico tradizionale perché, opportunamente adattato alla pratica d’aula, non sovrappone modelli del tutto diversi a schemi mentali preesistenti.
Grammatica della coesione testuale: determinanti e pronomi
La competenza testuale è una componente centrale della competenza linguistica, e anche quella che si acquisisce più tardi e più faticosamente. La coesione è quell’aspetto della testualità che si manifesta attraverso la presenza di legami propriamente linguistici tra le parti di un testo legandosi al “nocciolo” morfosintattico della riflessione grammaticale. Il presente percorso mette a fuoco i due strumenti di coesione di carattere più propriamente grammaticale: la classe dei determinanti e la classe dei pronomi. Le due classi rappresentano una parte sostanziale di ciò che occorre capire per poter analizzare frasi e testi.
Ultime risorse pubblicate
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 839 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 744 [1] => 66 [2] => 607 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6705/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 837 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 840 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 744 [1] => 66 [2] => 607 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6704/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 837 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 841 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 544 [1] => 704 [2] => 705 [3] => 541 [4] => 4 [5] => 596 [6] => 540 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6701/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 842 [1] => 843 [2] => 844 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 705 [1] => 4 [2] => 675 [3] => 44 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6696/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 845 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 705 [1] => 4 [2] => 47 [3] => 45 [4] => 44 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6697/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 847 [1] => 849 [2] => 846 [3] => 850 [4] => 851 [5] => 852 [6] => 848 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 46 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6703/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 853 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 46 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6698/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 855 [1] => 854 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 45 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6699/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0