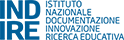Con questo contributo si è ipotizzata la costruzione di un percorso attraverso il quale poter consolidare negli studenti la concezione della poesia come linguaggio specifico in cui significante e significato si raccordano anche in base all’esperienza biografica dell’autore e alla concezione poetica di riferimento. Finalità dell’attività è di scandagliare le possibili analogie e differenze che intercorrono tra un testo poetico e il testo di una canzone d’autore, nonché le rispettive valenze letterarie o culturali e la funzione sociale; il progetto si propone inoltre di far acquisire consapevolezza della specificità espressiva della canzone d’autore (componente musicale e vocale), individuandone i rapporti con l’esperienza biografica dell’autore e la poetica di riferimento.