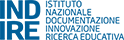La nostra cucina è ricca di dispositivi per riscaldare o raffreddare, di strumenti per mischiare, tagliare, affilare o misurare e infine di sostanze, gli ingredienti, che facciamo reagire tra loro nella preparazione delle nostre ricette.
Ogniqualvolta eseguiamo una ricetta siamo impegnati in un’investigazione scientifica: misuriamo gli ingredienti, li misceliamo o li facciamo reagire insieme, seguendo le istruzioni e per ultimo testiamo la consistenza e il sapore del prodotto del nostro esperimento, assaggiandolo.
In questa risorsa la cucina diventa il laboratorio scientifico che permette di investigare sulle trasformazioni che avvengono negli alimenti durante la loro preparazione e sulle diverse tecniche di conservazione e di cottura dei cibi.
Grado scolastico: Secondaria di I grado – III anno
Obiettivi:
• Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche nelle investigazioni con materiali rintracciabili in casa.
• Riconoscere le principali reazioni chimiche che interessano le investigazionicon materiali rintracciabili in casa.
• Classificare i composti in base alla loro natura: ionica o molecolare.
• Riconoscere che i materiali sono formati da particelle microscopiche separate da spazi vuoti.
• Comprendere che le particelle microscopiche, che compongono solidi, liquidi e gas, hanno massa e sono in costante moto.
• Spiegare che ci sono un centinaio di elementi diversi, ordinati nella Tavola Periodica, che si uniscono per formare le molecole dei materiali investigati.
Competenze:
• Spiegare che, a livello atomico-molecolare, i materiali indagati sono discontinui, anche se macroscopicamente appaiono continui.
• Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare le trasformazioni fisiche e chimichecon materiali rintracciabili in casa.
• Distinguere le osservazioni dalle spiegazioni delle trasformazioni fisiche e chimiche mediante il modello particellare.
• Registrare le osservazioni con un linguaggio chiaro, conciso e corretto.
• Spiegare che gli atomi e le molecole hanno alcune proprietà degli oggetti macroscopici (per esempio, massa e volume) ma non hanno altre proprietà fisiche come temperatura, colore, punto di fusione, punto di ebollizione, densità, ecc.
Tempo medio per svolgere il percorso in classe: 12 ore, più un giorno per la realizzazione dell’investigazione n. 10.
Prova di valutazione correlata:
Fragole e panna (di P. Fini)