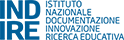This pathway presents an analysis of common problems with listening and speaking tasks followed by an explanation of how certain concepts can be integrated in a series of lessons in order to provide students with the best possible listening and speaking skills work.
Homepage
[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]
Ultime guide pubblicate
Seconda competenza chiave – Using authentic listening texts to improve listening and speaking skills
Sulle abilità scritte e strategie comunicative – Destrezas escritas y estrategias comunicativas
La tarea que se propone es la creación de una guía digital con una lista del patrimonio cultural de la clase que describa sitios culturales, naturales y mixtos, pertenecientes al entorno de los estudiantes y dignos de conservación. Aspectos que se tendrán en cuenta serán las tradiciones o leyendas autóctonas ligadas al sitio. Se pondrá en marcha un concurso para seleccionar el sitio más representativo de la comunidad clase. Las guías se presentarán eventualmente a la UNESCO o a las autoridades locales. El itinerario didáctico se articula en una serie de tareas intermedias para llegar a la fase final.
Le rocce raccontano II
Partendo dallo studio delle rocce, dalla natura dei minerali che le compongono e dalla tipologia dei processi che hanno portato alla loro formazione, gli alunni saranno condotti attraverso un percorso conoscitivo che insegnerà loro a interpretare i documenti scritti nei giacimenti rocciosi, riconoscendo, attraverso di essi, la natura dei fenomeni che hanno caratterizzato la storia geologica di un territorio. Importante sarà riuscire a favorire il processo di costruzione della conoscenza che non sia necessariamente di matrice costruttivista, ma che integri elementi di comprensione concettuale dei fenomeni investigati (come ad es., il processo di formazione di una roccia oppure come si uniscono i minerali) e delle relazioni causali (se la temperatura sale oltre un certo limite succede qualcosa?) le cui tracce si ritrovano nelle rocce, vere e proprie testimonianze del passato e del presente geologico di un territorio.
Per questo, dopo essere passati attraverso lo studio dei singoli fenomeni litogenetici, analizzandoli nelle loro caratteristiche peculiari, anche attraverso modellizzazioni e simulazioni di varia natura, si arriverà al riconoscimento delle rocce in contesti protetti o simulati (come quelli della classe o del laboratorio scolastico), per arrivare, infine, a osservarle in ambienti naturali e a utilizzarle come indizi, ovvero come fonti di informazioni per ricostruire la storia litologica (e non solo) di una certa zona.
Grado scolastico: Secondaria di II grado – I biennio
Obiettivi:
• Saper riconoscere il valore semantico dei termini usati per descrivere un fenomeno scientifico.
• Individuare le domande alle quali un’indagine scientifica cerca di dare risposta.
• Saper scomporre e ricomporre la complessità dei fenomeni indagati individuando elementi, relazioni e sottosistemi.
• Comprendere l’importanza di schematizzazioni, modelli e formalizzazioni logiche dei fenomeni indagati, e saperli applicare a semplici fenomeni.
• Proporre modi di esplorare scientificamente un problema dato, utilizzando anche procedimenti matematici (formule, ecc.).
• Saper individuare le scale dimensionali adeguate e le modellizzazioni appropriate al fenomeno da rappresentare.
• Raccogliere dati in contesti diversi, sia in situazioni controllate (laboratorio) sia sul campo, utilizzando diversi tipi di strumenti.
• Saper utilizzare ragionamenti e procedimenti logici elaborati in contesti controllati (laboratorio) a contesti ambientali complessi (strutture geologiche, rilievi, ambienti naturali diversi).
• Descrivere e utilizzare strumenti e metodi usati dalla scienza per garantire l’affidabilità dei dati (controllo delle variabili, gruppi di controllo, ripetizione delle misure,…).
• Elaborare e usare modelli e teorie per interpretare e spiegare le osservazioni e per predire osservazioni non ancora effettuate.
Competenze:
• Ricordare e applicare alla situazione problematica investigata le conoscenze scientifiche utili per risolverla.
• Riconoscere e distinguere cause ed effetti nei fenomeni considerati.
• Identificare e usare modelli e rappresentazioni esplicativi dei fenomeni in esame.
• Proporre modi di esplorare scientificamente un problema dato.
• Raccogliere dati in contesti diversi, sia in situazioni controllate (laboratorio) sia sul campo, utilizzando o costruendo diversi tipi di strumenti.
• Analizzare e interpretare i dati raccolti per trarne conclusioni appropriate.
• Elaborare ipotesi sulla base dei dati raccolti e delle conoscenze personali e formulare proposte di esperimenti atti a verificarle.
• Usare e elaborare quando possibile modelli e teorie per interpretare e spiegare le osservazioni e per predire osservazioni non ancora effettuate.
Tempo medio per svolgere il percorso didattico: 13-28 ore
Prova di valutazione correlata:
Il rischio idrogeologico (di M. Onida)
Il calcolo mentale: strategie e scorciatoie
Tematica affrontata:
Alla scoperta delle operazioni e delle loro proprietà: calcolo mentale e strumenti di calcolo.
Descrizione dell’attività:
L’attività qui presentata propone esperienze matematiche tese a sviluppare le competenze del calcolo mentale. A tal fine sono suggerite modalità di interazione costruttiva in classe per indurre gli allievi a usare la potente calcolatrice che ciascuno di noi ha: “la mente”.
Fin dai primi giorni di scuola i bambini contano caramelle, figurine, macchinine, i giorni, i compagni, ecc. Usano, a volte, le dita delle mani. Questo percorso sul calcolo mentale ha l’ambizione di restituire al “fare i conti a mente” uno spazio più ampio e significativo nel curricolo di matematica dalla prima alla quinta classe, accompagnando docenti e allievi alla scoperta del valore formativo delle strategie di calcolo, dei concetti e dei passaggi logico-formali usati per arrivare al risultato corretto. L’obiettivo è quello di favorire, attraverso lo sviluppo di strategie di calcolo fondate sulle proprietà delle operazioni, la consapevolezza di tali proprietà, e lo sviluppo di processi di controllo. In concreto, si tratta di individuare scorciatoie di calcolo, evitando quando possibile il ricorso al calcolo scritto e usando, fin di primi giorni di scuola, gli strumenti “naturali” di cui ognuno di noi, fin da piccolo, dispone: le mani.
Obiettivi dell’attività:
• Sviluppare strategie per il calcolo mentale con numeri piccoli e grandi.
• Applicare in modo intuitivo le proprietà delle operazioni.
• Operare con le calcolatrici tascabili.
• Utilizzare il foglio di calcolo excel per eseguire operazioni con numeri piccoli e grandi, finalizzate allo sviluppo del calcolo mentale.
Grado scolastico: scuola primaria – dalla classe I alla classe V
Tempo medio per svolgere il percorso didattico: 12 ore
Semplice… la frase semplice? Riflessione sulla struttura della frase semplice e sulle funzioni dei suoi elementi
Il percorso propone la riflessione sulla frase semplice nella sua struttura, affrontando la questione delle funzioni grammaticali, come quella del soggetto. Di questo si analizzano i criteri più diffusi per individuarlo. Guardare alla frase semplice da più prospettive: semantica, comunicativa e sintattica, fa spostare l’attenzione sulla frase come un processo, la cui narrazione parte dal verbo, che con la sua carica semantica attira a sé alcuni elementi necessari per attivare la sua funzione predicativa del soggetto (frase nucleare). Oltre questi elementi la frase semplice può presentare elementi sussidiari alle funzioni di base, a queste non sempre sintatticamente legate.
Social Media, Social Software e Social Network: un’introduzione
Il materiale multimediale è consultabile via computer e tablet.
CONTENUTO:
il tutorial ha l’obiettivo di presentare un gruppo significativo di siti di social networking (LinkedIn, Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Instagram, Google Plus, Snapchat), riportando per ognuno:
- 1. caratteristiche
- 2. le fonti di profitto
- 3. la storia
- 4. le funzioni principali.
Progetto Lucca. Presentazione della città di Lucca ed intervista a turisti stranieri
Il percorso propone una riflessione su alcune problematiche inerenti le strategie linguistico – comunicative, tra cui le strategie di cooperazione e compensazione, alle quali gli apprendenti ricorrono nel corso di interazioni e di esposizioni.
Il percorso intende anche analizzare i comportamenti culturali e linguistici manifestati dagli interlocutori durante le interazioni. A questo fine si propone la visualizzazione e l’analisi di video che documentano un progetto didattico realizzato da studenti e studentesse del liceo scientifico Vallisneri di Lucca.
La traduzione dal greco come prova d’esame.
Esercizi propedeutici, strategie operative e governo del tempo, competenze accessorie: i confronti, il dizionario, la rete
L’esame conclusivo del liceo classico prevede come seconda prova possibile la traduzione di un testo greco. Il percorso è concepito come istruzione sia per il docente sia per lo studente e prevede rispettivamente una serie di “lezioni” teoriche e pratiche sul procedimento traduttivo e una serie collegata di esercizi.
Oggetti dell’insegnamento apprendimento saranno le strategie di lettura e decodifica del testo di partenza, le diverse stesure del testo di arrivo, il governo del tempo, l’acquisizione delle competenze correlate alla traduzione (uso del dizionario e confronti traduttivi).
Trattandosi di un percorso da spendere nella scuola di oggi, un’attenzione particolare e specifica verrà data all’uso degli strumenti informatici.
Le ombre: una prospettiva geometrica
Nell’età di formazione scolastica, specie nelle fasi in cui le capacità di astrazione sono in costruzione, la matematica e le scienze dovrebbero viaggiare strettamente unite, in modo da costruire i concetti e le teorie matematiche partendo da problemi scientifici e, simmetricamente, imparare a matematizzare i collegamenti fra i fenomeni che si osservano.
Da questo punto di vista lo studio delle ombre costituisce un ambito privilegiato, perché può diventare, da gioco di osservazione nella scuola primaria, analisi di proprietà geometriche piuttosto raffinate.
In questo materiale di studio vengono proposte alcune attività di questo tipo e vengono date alcune indicazioni sul rapporto ombre-geometria, in modo che anche i docenti che non hanno avuto, nel loro corso di studi, esperienza diretta di questi argomenti, possano trarre qualche vantaggio conoscitivo, vedendo dove si può andare a parare se si intraprende un percorso sulle ombre.
Il ciclo di apprendimento di Karplus
Diversi studi pongono in evidenza che l’apprendimento delle discipline scientifiche, dalla scuola dell’infanzia all’università, è ostacolato dalla mancata comprensione del significato delle parole. L’insegnamento dei concetti scientifici, in una classe tradizionale, destina uno spazio molto limitato alle investigazioni, alla lettura, alla scrittura, alle domande. In una lezione tradizionale il docente presenta un concetto scientifico (magari con una sorprendente dimostrazione), denomina (dettando la definizione del concetto), valuta la comprensione dello studente. Stante questa prassi, gli allievi vedono la scienza come la compilazione di una serie di risposte corrette, la cui correttezza è ratificata dal docente o dal libro di testo.
Negli anni ‘60 Robert Karplus e Herbert Thier in USA decisero di occuparsi dell’insegnamento delle scienze nelle scuole primarie col progetto Science Curriculum Improvement Study (SCIS) e di ribaltare lo scenario negativo descritto all’inizio.
Quale fu il metodo utilizzato dal progetto?
Nel 1967 i due autori americani inventarono il ciclo di apprendimento di Karplus e decisero di applicarlo al progetto SCIS. In questo materiale di studio viene presentato questo approccio all’insegnamento scientifico che trova applicazione in alcuni dei percorsi didattici dell’area “Trasformazioni”.
Ultime risorse pubblicate
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 839 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 744 [1] => 66 [2] => 607 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6705/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 837 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 840 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 744 [1] => 66 [2] => 607 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6704/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 837 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 841 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 544 [1] => 704 [2] => 705 [3] => 541 [4] => 4 [5] => 596 [6] => 540 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6701/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 842 [1] => 843 [2] => 844 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 705 [1] => 4 [2] => 675 [3] => 44 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6696/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 845 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 705 [1] => 4 [2] => 47 [3] => 45 [4] => 44 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6697/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 847 [1] => 849 [2] => 846 [3] => 850 [4] => 851 [5] => 852 [6] => 848 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 46 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6703/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 853 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 46 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6698/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 855 [1] => 854 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 45 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6699/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0