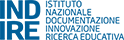Il percorso vuole inquadrare, a partire dalla derivazione delle parole, il fenomeno della nominalizzazione che spesso non viene fatto oggetto di attività didattica. Tale fenomeno dovrebbe occupare un posto di rilievo nell’educazione linguistica in quanto coinvolge meccanismi morfologici derivativi delle parole, aspetti lessicali e sintattici ed interviene anche nei processi cognitivi di lettura e scrittura, comportando effetti comunicativo-pragmatici particolari.
Cognizione fondante è il morfema nella sua ripartizione in morfema lessicale e grammaticale. Il percorso affronta in modo graduale i principali meccanismi di formazione di parole nuove (suffissazione, prefissazione e conversione) quindi il fenomeno della nominalizzazione che li utilizza.
La nominalizzazione è un nome morfologicamente derivato da un verbo, inserito in un sintagma che esprime il contenuto di una frase. È un fenomeno linguistico che:
– a livello cognitivo aiuta a semplificare il discorso svolgendo un’efficace funzione di sintesi e coesione del testo attraverso la generazione di enunciati più brevi;
– a livello linguistico superficiale oscura l’idea di processualità e di progressione espressa dai verbi presentando gli eventi come cristallizzati;
– a livello pragmatico permette una rappresentazione della realtà da cui scompaiono gli agenti e per questo raggiunge uno stato di astrattezza e asetticità proprio di alcuni linguaggi.
Homepage
[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]
Ultime guide pubblicate
La nominalizzazione: un fenomeno di confine tra morfologia, sintassi e lessico
Introduzione alla linguistica generale e italiana
Il Materiale di studio proposto si compone di una parte introduttiva sulle lingue naturali nei vari modi di comunicare, viene introdotto il concetto di multimodalità e di linguaggi non verbali, all’interno dei quali si colloca la lingua verbale e il concetto di assi di variazione. Una seconda parte dell’unità teorica è costituita dalla morfologia, della quale viene spiegata la rilevanza funzionale: creare parole nuove (soprattutto nella pubblicità). Nella parte conclusiva si parla di comunicazione intesa come interazione nella vita quotidiana e/o interazione in classe. Infine vengono presentati alcuni cenni sul testo e sui relativi concetti di coerenza e coesione, e sulla tipologia testuale. Si propone inoltre un approfondimento su fonetica e fonologia. Si presenta l’alfabeto fonetico internazionale IPA. Dalla riflessione sulla fonologia si arriva all’ortografia. Infine sono stati inseriti nell’unità teorica alcuni accenni alla sintassi e alla distinzione tra frase ed enunciato.
Come valutare i risultati di una didattica laboratoriale
La didattica laboratoriale ha bisogno di strumenti di valutazione coerenti e adeguati agli obiettivi che si propone. Il Materiale di studio discute diversi obiettivi – sviluppare l’interesse per le scienze, promuovere il lavoro di gruppo e l’apprendimento collaborativo, costruire le competenze necessarie per un’indagine scientifica – e propone schede, rubriche e griglie per raccogliere i dati necessari alla loro valutazione.
Conoscenza di senso comune e conoscenza scientifica
Preconoscenze, rappresentazioni mentali, concetti spontanei, conoscenza di senso comune, misconcetti: diversi sono i termini utilizzati in molte pubblicazioni, e anche nei percorsi PON, per indicare la necessità di tenere conto, per costruire nuove conoscenze, di ciò che lo studente già sa, anche se in maniera implicita.
I termini non sono esattamente equivalenti e sono significativi dei diversi approcci che si possono avere al problema; pertanto, questo Materiale di studio si propone di esplorarne i significati, anche attraverso esempi concreti, e di illustrare alcuni strumenti per la loro valutazione, collegati ai percorsi proposti e in parte già presenti tra le prove di valutazione proposte dal PON.
La valutazione delle competenze
La valutazione fa parte da sempre della professionalità insegnante: il docente valuta l’alunno – così come in passato il mastro artigiano valutava l’apprendista – dando giudizi impliciti o espliciti sulla qualità del suo apprendimento, sul suo comportamento, sulle competenze che mostra di possedere quando gli si lascia autonomia di scelta ed applicazione. La valutazione avviene quindi durante ogni scambio e ogni relazione, anche quando questa valutazione rimane implicita e non si trasforma in giudizio o in voto.
La valutazione è inoltre un processo bidirezionale: anche quando ne ignoriamo i risultati gli studenti ‘giudicano’ il proprio insegnante, raccolgono informalmente ‘dati’ sul suo comportamento e si comportano di conseguenza. I comportamenti degli studenti sono infatti strettamente correlati ai criteri di valutazione degli insegnanti (per ‘rispondere correttamente’ a una domanda le regole cambiano da insegnante a insegnante), mentre i loro giudizi sugli ‘insegnanti’ sono correlati ai loro bisogni e non sempre rispondono a esigenze di crescita ‘culturale’; al primo posto c’è infatti il bisogno di ‘esser promosso’, per cui a volte sono considerati “bravi” proprio gli insegnanti ‘troppo buoni’, cioè quelli che non richiedono impegno. Per questo è importante che gli studenti capiscano il perché delle richieste dei docenti e i criteri coi quali verranno valutati, così da poter soddisfare il loro ‘bisogno primario’: quello d’essere apprezzati.
Una valutazione coerente con il modello di apprendimento del PON Educazione scientifica
Il modello di apprendimento del PON Educazione scientifica, oltre a tener conto delle proposte sulla valutazione – e quindi anche sui processi cognitivi da sviluppare – presenti nelle ricerche internazionali TIMSS e PISA, si ispira a quanto sperimentato dal Piano ISS e segue le Indicazioni nazionali ed europee riguardo conoscenze e competenze degli studenti.
Nel modello proposto:
– le competenze si costruiscono all’interno di contesti e sono tanto più profonde e trasferibili quanto più i contesti d’apprendimento sono funzionali al processo, diversificati e collegati alla vita reale;
– è ribadita l’importanza del riuscire a suscitare motivazione e interesse nei giovani, così com’è essenziale da parte del docente porre l’accento sul senso di ciò che propone in classe e più in generale sulle procedure e il valore del ‘fare scienza’;
– oltre alle conoscenze ‘della scienza’ particolare attenzione è data alla conoscenza ‘sulla scienza’, alla consapevolezza cioè su come procede la scienza e sul ruolo che ha avuto e che ha nella società; soprattutto la storia della scienza e l’educazione allo sviluppo sostenibile offrono contesti all’interno dei quali riflettere sulla natura della scienza e sulla responsabilità verso il futuro dell’umanità che essa richiede.
In coerenza col modello di apprendimento del PON Educazione scientifica, la valutazione può esser sia sommativa, attraverso prove di verifica di conoscenze e/o di competenze acquisite, sia formativa, tramite prove di verifica e relazioni (individuali e/o di gruppo) mirate a una riflessione su quanto è stato fatto, e soprattutto attraverso strumenti di valutazione ‘autentica’, quali la raccolta delle domande e degli interventi più significativi, l’osservazione dei comportamenti, i diari di bordo di alunni e insegnante.
Le trasformazioni fisiche, ovvero vapore di ferro e aria solida
Il Materiale di studio supporta gli insegnanti di scienze della scuola secondaria di primo grado ad approfondire la conoscenza dei materiali e delle loro proprietà durante e dopo le trasformazioni fisiche e chimiche. Mette inoltre in condizione di applicare quanto appreso a problemi reali riguardanti la conservazione ambientale e la qualità dell’aria e dell’acqua. Il Materiale di studio aiuta a costruire anche altre competenze, fra cui correlare le trasformazioni fisiche e chimiche dei materiali alla natura delle particelle costituenti, valutare e utilizzare i dati raccolti per spiegare le trasformazioni fisiche e chimiche, porre domande, investigare e interpretare le evidenze raccolte.
Il modello particellare della materia
Gli oggetti che tocchiamo con le mani e che vediamo con gli occhi, e anche tante altre cose che non vediamo (come i gas), appartengono a quel mondo che noi chiamiamo “mondo materiale”. La materia è formata in genere da materiali, che sono miscugli più o meno complessi di sostanze pure. Ma che cosa sono le sostanze pure, da un punto di vista microscopico?
L’oro (Au), il ferro (Fe) e l’alluminio (Al) sono esempi di elementi solidi a noi noti e che possiamo riconoscere facilmente a livello macroscopico. Immaginiamo ora di dividere un oggetto di alluminio in campioni sempre più minuti: dopo numerosissime suddivisioni possiamo immaginare di arrivare a una singola particella, quella che chiamiamo “atomo”.
La chimica verde
L’insegnamento della chimica nel XXI secolo deve aver come punto di riferimento le nuove considerazioni etiche fissate dai principi di “chimica verde”, elaborati nel 1998 da Paul T. Anastas e John C. Warner. La chimica verde richiede “l’utilizzazione di una serie di principi che riducono o eliminano l’uso o la produzione di sostanze pericolose nel processo di preparazione di prodotti chimici”.
Piuttosto che pensare di ridurre la contaminazione individuale e ambientale soltanto con l’impiego di occhiali, guanti di lattice e cappe aspiranti, la chimica verde consiglia di sostituire i reagenti e i solventi pericolosi con altri materiali.
Le investigazioni sulla chimica verde comportano l’utilizzo di reagenti ecocompatibili e sicuri per la salute degli allievi che li manipolano.
La chimica a casa
Molti ambienti domestici e in particolare la cucina e la stanza da bagno possono essere considerati veri e propri laboratori scientifici. Gli ingredienti, che si usano nelle attività domestiche, sono formati da composti chimici, alcuni complessi (zuccheri, grassi, detergenti, polveri lievitanti) e altri molto semplici (acqua, alcol, sale, bicarbonato di sodio, acido acetico). Tali ingredienti saranno impiegati, descritti e spiegati nelle molte investigazioni che accompagnano questa risorsa. In particolare saranno descritti i componenti e le modalità operative per preparare elementi e composti utili.
Grado scolastico: Secondaria di I grado – III anno
Obiettivi:
• Distinguere le trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche nelle investigazioni con materiali rintracciabili in casa.
• Riconoscere le principali reazioni chimiche che interessano le investigazioni con materiali rintracciabili in casa.
• Classificare i composti in base alla loro natura: ionica o molecolare.
• Riconoscere che i materiali sono formati da particelle microscopiche separate da spazi vuoti.
• Comprendere che le particelle microscopiche, che compongono solidi, liquidi e gas, hanno massa e sono in costante moto.
• Spiegare che ci sono un centinaio di elementi diversi, ordinati nella Tavola Periodica, che si uniscono per formare le molecole dei materiali investigati.
Competenze:
• Spiegare che, a livello atomico-molecolare, i materiali indagati sono discontinui anche se macroscopicamente appaiono continui.
• Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche con materiali rintracciabili in casa.
• Distinguere le osservazioni dalle spiegazioni delle trasformazioni fisiche e chimiche mediante il modello particellare.
• Registrare le osservazioni con un linguaggio chiaro, conciso e corretto.
• Spiegare che gli atomi e le molecole hanno alcune proprietà degli oggetti macroscopici (per esempio, massa e volume) ma non hanno altre proprietà fisiche come temperatura, colore, punto di fusione, punto di ebollizione, densità, ecc.
Tempo medio per svolgere il percorso in classe: 12 ore, più quattro giorni per la realizzazione dell’investigazione n. 3 e un giorno per la realizzazione dell’investigazione n. 10.
Prova di valutazione correlate:
Festa di Carnevale (di P. Fini)
Ultime risorse pubblicate
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 839 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 744 [1] => 66 [2] => 607 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6705/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 837 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 840 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 744 [1] => 66 [2] => 607 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6704/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 837 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 841 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 544 [1] => 704 [2] => 705 [3] => 541 [4] => 4 [5] => 596 [6] => 540 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6701/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 842 [1] => 843 [2] => 844 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 705 [1] => 4 [2] => 675 [3] => 44 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6696/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 845 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 705 [1] => 4 [2] => 47 [3] => 45 [4] => 44 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6697/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 847 [1] => 849 [2] => 846 [3] => 850 [4] => 851 [5] => 852 [6] => 848 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 46 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6703/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 853 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 46 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6698/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0
- autorerisorsa:
Array ( [0] => 855 [1] => 854 ) - disciplinecopertina:
Array ( [0] => 4 [1] => 45 ) - collezionecopertina: 27
- istituzionicopertina:
- destinatarioprevalente:
Array ( [0] => 87 ) - ordinediscuole:
Array ( [0] => 66 ) - inserimentofiles: 0
- inserimentourl_0_indirizzofile: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6699/
- inserimentourl_0_tipologiacopertina: 745
- inserimentourl: 1
- tipologiadirisorsa:
Array ( [0] => 838 ) - annodipubblicazione: 2015
- condizioniuso: 85
- settingtecnologico:
- question: 0
- question2: 0