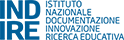La risorsa intende avvicinare gli studenti alla funzione narrativa della poesia, ad iniziare dalla narrazione lunga dantesca, che accompagna il lettore attraverso esperienze immaginate e al contempo realistiche e che molto insegnano su un’età tanto distante dalla nostra. L’approccio alle forme poematiche passa attraverso singole liriche che dal Canzoniere petrarchesco, che apre alla rappresentazione dell’interiorità, approda alle autobiografie del primo Novecento, testimoniando, con Govoni, la ribellione estetica alla poesia tradizionale e la proposta trasgressiva delle forme futuriste ma anche la ripresa delle esperienze esistenziali di Pascoli e di Saba e quelle drammatiche vissute da Ungaretti durante la prima guerra mondiale.