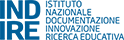Tematica affrontata: ambiente di apprendimento: risorse e limiti.
La risorsa, articolata in tre fasi, invita a riflettere sul significato dell’espressione “ambiente di apprendimento” e sulle relative componenti “reali” (la scuola, l’aula, le attrezzature, le opportunità offerte dal territorio, ecc.), mentali (il carattere degli allievi, il loro vissuto, il loro bagaglio culturale, ecc.), virtuali (il web) legate al docente (metodo di insegnamento, capacità professionali, ecc.) o al discente. Ognuno di questi fattori influisce in varia misura sul processo di apprendimento dell’allievo e il confluire di due o più di questi fattori può determinare il fallimento o il successo dell’azione didattica. Alla fine del percorso il docente avrà acquisito la capacità di:
– interpretare correttamente il significato dell’espressione “learning context”;
– valutare il proprio contesto scolastico nelle sue varie varianti;
– utilizzare il web quale risorsa di insegnamento;
– valutare l’apporto delle nuove tecnologie nelle pratiche di insegnamento;
– promuovere la sperimentazione e l’uso di nuovi spazi di apprendimento attraverso l’utilizzo dei nuovi media;
– pianificare un percorso di apprendimento che sia innovativo e più attinente alla sensibilità dei giovani discenti;
– lavorare “in squadra” collaborando con altri colleghi in presenza o in rete;
– elaborare un progetto CLIL su argomenti di interesse generale;
– progettare una griglia di valutazione. Il percorso è in grado di promuovere negli studenti:
– una partecipazione più attiva alle attività didattiche;
– lo sviluppo della loro creatività;
– un uso corretto degli strumenti multimediali;
– la capacità di lavorare in gruppo (reale o virtuale) collaborando e suddividendosi i compiti;
– l’osservazione delle regole del vivere civile, l’auto-controllo e il rispetto per gli altri;
– l’autonomia di apprendimento; – la consapevolezza della dimensione europea della cultura.