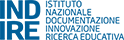Il videolab prende spunto da un foglio del “Codice Atlantico” in cui Leonardo descrive e illustra con minuta attenzione la fiamma di una candela: dalla sua generazione alla combustione, alle variazioni cromatiche e di movimento; dalla sua morfologia alle interazioni tra fiamma e aria circonvicina e come quest’ultima ‘reagisce’ in relazione al fluttuare di una fiammella. Il videolab ci conferma Leonardo “Uomo Universale”: l’osservazione di una candela accesa permette al grande genio di spaziare tra argomenti di fisiologia, idraulica, anatomia, fisica (nella sua concezione generale e dell’atmosfera in particolare) e, non ultimo, di esporre riflessioni di natura filosofica.
Attività:
• Tre candele affiancate
• L’ombra della fiamma
Le attività consistono nell’osservazione diretta e nella verifica di quanto cinematicamente illustrato da Leonardo circa la morfologia della fiamma e le dinamiche d’interazione e di movimento che innesca attorno a sé.
Durata del video: 35′ 48″